|
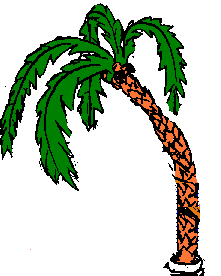  |
|
|
|
|
Ten. Col. Paolo Caccia Dominioni
Paolo Caccia Dominioni (1896-1992) si arruola volontario nella Prima guerra mondiale sul fronte del Carso. Socio di uno studio di ingegneria del Cairo, a cui il Dipartimento egiziano per l’Irrigazione aveva commissionato una serie di disegni di alcune dighe dell’Alto Nilo, Caccia Dominioni entra a far parte dei servizi di spionaggio dell’Italia, che in quel periodo si prepara ad attaccare l’Etiopia, e mentre segue i lavori idraulici porta a termine anche la sua attività informativa. Rientrato ad Asmara, con il grado di Capitano, gli viene affidato l’incarico di costituire una pattuglia di esploratori, composta di “ascari” che parlino arabo, tigrino ed amarico, destinata a muovere in testa alle colonne in avanzata, per riconoscere il terreno, e ottenere dagli abitanti informazioni sugli itinerari da seguire per raggiungere Gondar e il Lago Tana. Vennero così aperti ben 275 km di pista e di strada. Ma l’esperienza in Africa non era terminata per lui, che oltre all’inglese, al francese e al tedesco conosceva anche l’arabo ed aveva avuto modo di apprezzare l’ambiente africano fatto di assoluta fedeltà all’onore militare, di alto senso del dovere e di grande spirito di sacrificio e coraggio. La Seconda Guerra Mondiale lo trova ad Ankara dove dirige i lavori per la costruzione della nostra Ambasciata in Turchia, da lui progettata. Viene di nuovo arruolato e, anche se conosce molto bene i nostri limiti strategici e la difficoltà di vittoria, continua ad essere utile al suo Paese entrando a far parte del Genio Guastatori Alpini. Alla fine del 1940 è in Libia, nella battaglia della Marmarica e nella offensiva italo tedesca di Tobruk.
Il Maggiore Caccia Dominioni prende parte alla battaglia di El Alamein con il suo 31mo Guastatori ed infine combatte ad Asiago dove lo coglie l’armistizio. Sollecitato da più parti a rientrare in servizio nell’Esercito del Nord, decide di entrare nella Resistenza. Alla fine della guerra accetta di tornare al Cairo per riprendere il lavoro nello studio di ingegneria e lì, nel 1949 il Console d’Italia, Alfredo Nuccio, gli affida la ricerca e la sistemazione dei Caduti Italiani, ancora dispersi nelle sabbie del territorio che va dalla Libia ad El Alamein: oltre 220Km! Caccia Dominioni e il suo commilitone Chiodini, facendo base alla famosa Q33 (la “Quota 33”, conquistata dai Marò del San Marco alla fine della corsa da Tobruk ad El Alamein), dal 1948 al 1954 riescono a raccogliere, censire e inumare i caduti rinvenuti nella vasta zona loro affidata in un unico cimitero vicino a Q33 “per mettere in evidenza il sacrificio italiano tanto ignorato da tutti”: sono 490 italiani, 465 tedeschi, 208 alleati, 63 ignoti di nazione ignota per un totale di 1.226. Inoltre raccolgono provenienti da altri minori cimiteri della zona: 893 italiani, 975 tedeschi, 205 libici per un totale generale di 3.299 salme! Ben presto, però, Caccia Dominioni si rende conto che, il Q33, troppo vulnerabile al trascorrere del tempo a causa delle imponenti infiltrazioni di acqua, avrebbe dovuto essere sostituito con una nuova e più grande opera cimiteriale che lui stesso progetta ed esegue. Mentre procedevano i lavori ad El Alamein, Caccia Dominioni, promosso Tenente Colonnello, viene mandato a Murchisono (Australia) per realizzare il Sacrario che oggi custodisce le salme dei soldati deceduti laggiù in prigionia. Il sacrario di El Alamein viene completato nel 1958 e vi saranno traslate 5.364 salme di Italiani riesumate dal cimitero di Q33, che ritorna ad essere un’anonima parte del deserto; le ricerche di altri dispersi continueranno fino al 1962. Secondo statistiche ufficiali sembra che in terra egiziana i caduti siano stati 4.825, 11 dei quali successivamente rimpatriati e 4.814 tumulati nel sacrario di El Alamein. Di esse 2.465 hanno un nome, 2.349 rimarranno per sempre ignote. Le spoglie di 1.095 soldati non sono state ritrovate e rimarranno “disperse” in eterno. Congedato dall’esercito, Caccia Dominioni riprende il suo vecchio mestiere di ingegnere progettista e in questa veste gli viene commissionata l’ala del paracadutista, nella piazza dei Caduti a Viterbo e in un caserma a Livorno; la Cappella della Folgore a Castro Marina; il monumento all’artigliere da montagna ad Udine, quello di Amedeo d’Aosta e quello degli “infoibati” a Gorizia; la cappella degli alpini del battaglione “Morbegno” e, infine, il Sacrario di Hammangi a Tripoli e quello dei Caduti d’Oltremare di Bari, che Caccia Dominioni progetta rifacendosi allo schema di Hammangi (v. scheda).
Nel 1983 il commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra gli commissionò una meridiana da collocare su Q33 e gli propose di metterla in sito personalmente. Cosa che fece con grande orgoglio alla veneranda età di 87 anni.
Ogni anno, nell’anniversario della battaglia di Alamein, alla fine di ottobre, viene tenuta una sontuosa cerimonia internazionale, la cui organizza- zione compete a turno all’Italia, alla Germania o alla Gran Bretagna, che dà vita ad un grande momento di incontro e di commozione. I veterani, anche se sempre meno numerosi, vanno a portare un fiore ed un saluto ai commilitoni caduti e là sepolti. Colpisce vedere uomini di oltre 80 anni e di nazionalità nemiche all’epoca della guerra che si ritrovano, fraternizzano, si abbracciano e indossano con fierezza i loro copricapi e le decorazioni di allora; hanno ancora un atteggiamento fiero, deciso e trasmettono fede, entusiasmo e amor di Patria. Questi eventi, i sacrifici e sentimenti di questi uomini fieri, dovrebbero essere fatti conoscere alle generazioni più giovani, per ricordare coloro che sono stati meno fortunati e a monito di tutte le guerre future.
Charles de Foucauld
Charles de Foucauld nasce a Strasburgo nel 1858. Rimasto orfano viene adottato dal nonno materno del quale seguirà la carriera militare. Tenente dell'esercito francese di stanza in Algeria, nel 1885, terminata la campagna militare si dimette dall’esercito e rimane in Africa perché ne è attratto e perché gli permette di dedicarsi alle ricerche etnografiche del Sahara. È proprio al deserto d’Algeria, allo studio delle tradizioni e costumi tuareg (ne imparerà la lingua), che dedica una parte della sua vita. Però de Foucauld è anche un uomo alla ricerca di Dio. "Per dodici anni, ho vissuto senza alcuna fede: nulla mi pareva sufficientemente provato. L'identica fede con cui venivano seguite religioni tanto diverse mi appariva come la condanna di ogni fede.. Per dodici anni rimasi senza nulla negare e nulla credere, disperando ormai della verità, e non credendo più nemmeno in Dio, sembrandomi ogni prova oltremodo poco evidente". Nel 1901 è ordinato sacerdote e il 28 ottobre dello stesso anno fissa la sua residenza a Bénis-Abbès (Algeria), dove costruisce un eremo per fondare una fraternita dove le sue meditazioni e i suoi ritiri diventeranno silenzi e scritti per dar modo alle popolazioni del Sahara di conoscere direttamente le verità cristiane. Sensibilizza le Autorità sul dramma della schiavitù e riesce ad affrancare parecchi schiavi Nel 1905 si trasferisce a Tamanrasset e lì costruisce un piccolo romitorio; farà altrettanto nel 1910 cin la costruzione di un eremo nell'Aschrem, sull'Hoggar, in difesa dei tuareg. Fu proprio nel 1907 che Charles de Foucauld inizia un grandissimo lavoro scientifico sui canti, poesie e proverbi degli “uomini blu”. “continuare nel Sahara la vita nascosta di Gesù a Nazareth, non per predicare, ma per servire nella solitudine la povertà e l’umile lavoro di Gesù” Esausto, Charles, si ammala e saranno proprio i tuareg che lo salveranno dividendo con loro il poco latte di capra in un periodo di siccità. Solo allora, capisce che l’amicizia e l’amore tra fratelli passa attraverso lo scambio e la reciprocità. “Il mio apostolato deve essere l’apostolato della bontà. Vedendomi la gente deve dire: poiché quest’uomo è buono…la sua religione deve essere buona” Nel 1914 scoppia la guerra in Francia e anche nel deserto la situazione non era tanto tranquilla per la presenza di razziatori marocchini e minacce dei Senussi libici che scorazzavano liberamente per l’assenza dei soldati francesi richiamati al fronte europeo. La vita di padre de Foucauld si conclude tragicamente il 1° dicembre 1916 quando un gruppo di tuareg, comandati da alcuni Senussi lo catturano e lo legano. Forse, si sarebbe potuto salvare se, nel tentativo di avvertire due ignari meharisti francesi, non si fosse messo a gridare del pericolo che stavano correndo. Per se aveva voluto “povertà, abiezione, umiliazione, abbandono, persecuzione e sofferenza” che lo avevano convinto di quanto povera fosse la vita dell’uomo e quanto era stato conquistato dalla nuda bellezza del deserto che lo aveva aiutato ad avvicinarsi a Dio.
Isabelle Eberardt
L’amazzone del Sahara Isabelle Eberhardt nacque a Ginevra, il 17 febbraio 1877. Sua madre era una aristocratica tedesca di origine russa, Natalia Nicolaevna Eberhardt e suo padre non era il marito di sua madre – il generale Moerder – ma Aleksandr Nicolaievitch Trofimoskij, un sacerdote ortodosso russo, amante della madre che però non riconobbe Isabelle come sua figlia. Anche se Isabelle era una ribelle, il fatto di essere figlia illegittima ha influito moltissimo sul suo bisogno di assumere identità diverse, di nascondersi dietro pseudonimi anche maschili, sulla sua inclinazione a raccontare storie inventate sulle sue origini. Questo dato è importante nella vita di Isabelle e per comprenderlo a pieno è necessario risalire all’aprile del 1871 quando la signora Natalia Nicolaevna Eberhardt (coniugata con il senatore luogotenente dello Zar Pavel de Moerder di ben 41 anni più anziano di lei) lascia San Pietroburgo per motivi di salute. Meta è la Svizzera, all’epoca considerata un toccasana per chiunque fosse debilitato o cagionevole. E’ accompagnata dal marito, da tre dei suoi figli: Nicolas, Natalia e Vladimir, dal figlio di primo letto del marito, Costantin, e dal precettore Aleksandr Trofimoskij. La signora de Moerder - a poco più di trenta anni - ha già cinque figli ed ha avuto numerosi aborti. Le gravidanze l’hanno spossata; oltretutto, durante il viaggio, si rende conto di essere nuovamente incinta. Nell’aprile del 1871, la famiglia de Moerder raggiunge la Svizzera, ma nell’estate dello stesso anno il senatore rientra da solo a San Pietroburgo mentre la moglie si trattiene ancora e, l’11 dicembre 1871, mette al mondo Augustin, quello che sarà il fratello prediletto di Isabelle, il suo Tino amatissimo. La salute di Natalia Nicolaevna è sempre cagionevole e i medici le consigliano di prolungare ancora per un anno il soggiorno e quando il generale de Moerder muore, a San Pietroburgo, nel 1873, Natalia Nicolaevna è ancora in Svizzera.. Aleksandr Trofimoskij - il futuro padre di Isabelle - è un personaggio singolare; era colto e di bell'aspetto. Sposato con tre figli e ottimo precettore. Fervente ammiratore di Tolstoj, e molto amico e simpatizzante delle idee anarchiche di Bakunin e di Protopkin. La sua casa era frequentata da anarchici, nichilisti, cospiratori e rivoluzionari di diverse nazionalità e proprio per questo, la polizia elvetica sorvegliava costantemente i membri della sua famiglia. Nel 1879, quando Isabelle non ha ancora compiuto due anni, Trofimoskij acquista una casa e un vasto terreno nei dintorni di Ginevra. La gente del posto la chiama la villa Tropicale perché il precedente proprietario, appassionato di botanica, coltivava piante grasse nelle serre vicine alla casa. Ed è in questa casa che Isabelle trascorre l‘infanzia. Trofimoskij insegna storia, lingue antiche e moderne, letteratura russa e straniera ai ragazzi maggiori; ma la tranquillità di questi primi anni viene spezzata da una serie di separazioni e fughe da parte dei figli. Nel 1883 Nicolas ritorna a San Pietroburgo, nel 1887, Natalia fugge con il fidanzato Alexandre Perez-Moreyra e poco dopo lo sposa. Anche Augustin, nel 1888, scompare per arruolarsi nella legione straniera. A causa di questi avvenimenti, Isabelle durante la sua adolescenza è molto sorvegliata. Viene sempre accompagnata nei suoi spostamenti da una governante o dalla madre, non può tenere una corrispondenza senza l’autorizzazione di Trofimoskij. In un unico campo le è concessa la massima libertà: può leggere qualsiasi libro le capiti sotto gli occhi: romanzi, memorie, poemi, saggi. I suoi romanzi preferiti sono quelli di Pierre Loti e di Lydia Pachkov. La voglia di sapere di Isabelle è insaziabile, spende somme considerevoli per acquistare libri di ogni genere e annota minuziosamente ogni suo acquisto, compra grammatiche d’italiano, d’inglese, di armeno, dizionari di greco, di persiano, di turco, di tedesco.....Inizia a studiare l’arabo e così si procura una decina di dizionari franco-arabi, il manuale dell’arabista in due volumi, alcuni saggi sull’Islam del XIX secolo, una grammatica cabila. Desidera diventare scrittrice. Nel 1895 il suo primo saggio di ispirazione africana, "Visions du Maghreb", scritto sotto lo pseudonimo di Nicolas Podolinsky, viene pubblicato dalla “Nouvelle Revue moderne”. Intanto, Augustin, il fratello tanto amato, è di nuovo in Algeria, nella legione straniera e Isabelle gli indirizza lettere dal tono accorato, si dispera, lo prega di tornare; gli racconta la disperazione della madre, ma non smette di coltivare il sogno di lasciare Ginevra e di viaggiare nei paesi arabi. Si mette in contatto con Eugène Letord, ufficiale francese in Algeria, che aveva messo un annuncio sul giornale al quale lei era abbonata - con lui si firmerà Nadia- e che le sarà amico fino alla fine; inizia a corrispondere con Abu Naddara, un letterato egiziano, un arabista, un tipo stravagante che viveva a Parigi e pubblicava un giornale: Abu Naddara Zarga. Isabelle gli manda auliche missive in arabo classico, chiede il parere del ’venerato sceicco” sui suoi lavori di traduzione dal russo all’arabo, che all’epoca non erano altro che puri esercizi di stile. Stavolta si firma I. de Moerder. Gli invia anche una foto - una delle più famose di lei - in abito maschile, vestita alla marinara, i capelli tagliati cortissimi. Ha poi ancora un altro corrispondente: un giovane tunisino di nobile famiglia, Ali Abdul Wahhab, colto, educato all’europea, il cui padre era governatore di Mahdia. Isabelle con lui si firma Nicolas Podolinsky, e a volte Meryem. E’ evidente, nel suo bisogno di camuffarsi dietro falsi nomi, la ricerca di una identità che ancora non ha preso corpo, il desiderio di spezzare la monotonia della vita quotidiana alla villa e il sogno di lasciare Ginevra. Il fratello Augustin è ancora in Algeria e proprio la ricerca del fratello sarà il pretesto della sua prima partenza per l’Africa del nord. Nel maggio 1897, infatti, Isabelle e la madre raggiungono Marsiglia e si imbarcano per Bona, che lei chiamerà sempre con il suo nome arabo di Annaba. A Bona la passione di Isabelle per il modo di vivere 'orientale' e per la religione musulmana si trasforma in un’ammirazione ragionata. Fu, infatti, durante questo primo soggiorno che decise di convertirsi. E la fede, anche nei periodi più cupi della sua vita non conobbe mai incertezze. Sempre a Bona si compie quella che per lei sarà una tragedia fonte di un dolore costante che l'accompagnerà per sempre: la morte della cinquantanovenne madre, affetta da pleurite. Ella ne è sconvolta, si sente finita. Il padre, Trofimoskij, la raggiunge ed insieme decidono di seppellire la signora de Moerder, anche lei convertita all'Islam, sotto il nome di Fatma Manoubia, nel cimitero musulmano di Bona. Quindi lasciano l’Algeria e ritornano in Svizzera. Isabelle, nonostante tutto, ha voglia di vivere, di viaggiare, di conoscere, ma nel 1898 l’attendono altre tragedie; l’altro fratello Vladimir, si suicida; il padre, Trofimoskij, si ammala gravemente di un tumore alla gola. Intanto Augustin è tornato a Ginevra e Isabelle si rende conto che il fratello prediletto è in realtà un inetto che non avrebbe mai concluso nulla nella vita. Il 15 maggio 1899 Trofimoskij muore. Per Isabelle la morte del padre è la chiusura del cerchio di tutto ciò che la lega alla villa Neuve e si rende conto che nulla più la trattiene. E' impaziente di disfarsi di quella casa triste, dove le morti si susseguono e che è stata, per lei, una sorta di prigione. Nel giugno 1899 si imbarca sul Saint-Augustin diretta a Tunisi e qui subisce il fascino della morte. Negli scritti "Heures de Tunis", così descrive quei giorni: "....Ho sempre amato vagare nei cimiteri musulmani, non hanno nulla di lugubre e di triste, pieni di fiori, di vigne e d'arbusti...". Inizia a vestirsi alla beduina, indossa candidi burnus, si rasa completamente i capelli, si spaccia per un giovane ragazzo: Mahmoud Saadi; la sua nuova identità prende finalmente corpo. I mesi successivi saranno caratterizzati da spostamenti continui. Ed è questo un dato costante in lei - a parte soste obbligate più o meno brevi - la sua esistenza è fatta di spostamenti da un Paese all'altro, in modo frenetico; solo la fede le darà un po' di pace, come dimostrano le considerazioni che annota nel suo diario. Nasce in lei anche una profonda visione fatalista dell'esistenza umana, che forse può essere la causa della sua inerzia nei confronti della successiva e precoce decadenza fisica e che le farà sostenere che tutto è scritto, tutto è maktub. Nel luglio del 1899 lascia la Tunisia diretta in Algeria. Arriva a Beja, poi a El-Khroub, e infine a Biskra. Probabilmente in questo periodo inizia a fumare kif, una droga, un misto di erbe ed hashish all'epoca non vietata. Continua a farsi passare per Mahmoud Saadi, giovane tunisino in pellegrinaggio da una zawiya all'altra. Ad agosto decide di spingersi verso Sud e raggiunge l'oasi di El-Oued. Nel suo libro "Au pays de sables", rievocherà quel momento: ".... il mio arrivo a El-Oued fu per me una rivelazione completa, definitiva, di quel Paese splendido: il Souf, della sua particolare bellezza ed anche della sua infinita tristezza". A settembre torna a Tunisi, quindi va a Sousse e Monastir. Scrive degli appunti di viaggio che saranno pubblicati con il titolo di "Notes sur le Sahel tunisien". In ottobre lascia Tunisi e torna a Marsiglia. Alla fine di novembre parte per Parigi, con l'intenzione di trattenersi qualche mese e di incontrare l'amico Ali Abdul Wahhab. Invece, il 16 dicembre, annota sul suo diario: "Rottura definitiva con Ali". Finisce così, per ragioni mai ben chiarite, un'intensa amicizia e una fittissima corrispondenza epistolare durata tre anni. Torna dunque a Marsiglia, quindi in treno va a Livorno dove si imbarca per la Sardegna. Il 1° gennaio 1900 arriva a Cagliari per incontrarsi con l'amato fratello Augustin che nel frattempo ha sposato Hélène Long, una ragazza incolta che Isabelle chiamerà sempre l'ouvrière, né perdonerà mai al fratello questo matrimonio. Nei suoi "Mes Journaliers" alla data del 1° gennaio 1900 scrive: "Sono solo, di fronte all'immensità grigia del mare mormorante, solo come lo sono sempre stato...". Usa il maschile in una ambiguità che in tutta la sua vita ha sempre usato. Prova un'intensa nostalgia per l'Africa. Annota ancora: "... Ritornare in Africa, riprendere quella vita, dormire nella frescura e nel silenzio profondo, avere per tetto il cielo infinito e per letto la terra...". Nell'agosto del 1900 è di nuovo a El-Oued. Qui Isabelle conosce Suliman Ehnni, l'uomo che dopo Ali Abdul Wahhab e il fratello Augustin ha più amato - Slimène, come lei lo chiama alla francese - un giovane ufficiale arabo del reggimento Spahi di El-Oued. Gli Spahi costituivano un reggimento di cavalleria, di origine turca, che i francesi avevano acquisito al loro servizio e francesizzato. Isabelle non conosce mezze misure, si innamora di lui follemente, in modo totale ed eccessivo. Ehnni sarà per lei un compagno fedele, un punto di riferimento costante nonostante le future, lunghe separazioni ed i suoi tormentati vagabondaggi, ma la salute di Isabelle inizia ad incrinarsi, si sente sempre più debole, si nutre sempre meno, fuma kif. La sua smania di vivere inizia ad avere connotazioni autodistruttive. Nel frattempo Slimène viene trasferito a Batna e lei è intenzionata a seguirlo; parte, dunque, a cavallo. Il 29 gennaio 1901, nelle prime ore del pomeriggio, si accampa a Béhima, ad una ventina di chilometri a nord-est di El-Oued. Isabelle è seduta, aiuta un’analfabeta a scrivere una lettera, il turbante le impedisce di notare l'uomo alle sue spalle. Questi la assale e le sferra un violento colpo al capo e due pugnalate alle braccia. Lei si accascia al suolo mentre i suoi amici disarmano l'attentatore. Il generale Dechizelle, comandante del settore militare francese di Costantina, attribuisce il crimine ad un atto di fanatismo religioso ed al fatto che Isabelle è affiliata alla Qadriyya ed in intimità con i capi della confraternita. Quella donna bizzarra comincia ad essere un personaggio scomodo, troppo particolare, troppo eccentrica. Dunque si rende necessario richiedere al console russo l'autorizzazione affinché sia espulsa dall'Algeria e questi autorizza di condurre alla frontiera "questa signorina russa che s'abbiglia in costume arabo....". Ai primi di maggio del 1901 Isabelle riceve l'avviso di espulsione. Fa una breve sosta a Batna per incontrare Slimène quindi si imbarca per Marsiglia. I due sono separati ancora una volta. La vita a Marsiglia le è intollerabile: non ha denaro, il suo amore è lontano, così come l’Algeria ma, verso la fine del mese, riceve una notizia insperata che le offre la possibilità di chiedere l'autorizzazione di rientrare e di far valere le sue ragioni. Viene, infatti, convocata dal tribunale di Costantina perché Abdallah Muhammad, il suo attentatore, sarà processato per tentato omicidio. A giugno rientra per testimoniare al processo che desta scalpore per l’abbigliamento arabo di Isabelle: una ragazza di buona famiglia europea, che parla innumerevoli lingue, vestita come un'indigena e che afferma di essere musulmana.... Abdallah, l'attentatore, dichiara che 'Allah gli ha ordinato di uccidere M.lle Eberhardt che, contrariamente alle nostre abitudini, si abbiglia in modo maschile e porta scompiglio nelle nostre regioni. Isabelle si difende. Le domandano dei suoi abiti maschili e lei risponde: "Monto a cavallo e li trovo più comodi". Le chiedono di cospirazioni e lei ribatte: "Non ho mai partecipato ad alcuna azione antifrancese..", come riporta ancora la Dépêche algérienne. Il processo le farà guadagnare il favore del pubblico. L'attentatore viene condannato a dieci anni di carcere, ed Isabelle, espulsa dall’Algeria, raggiunge Marsiglia con Slimène. Nell'ottobre del 1901, a Marsiglia, viene celebrato il loro matrimonio civile e ivi si stabiliscono, Slimène nel frattempo ha lasciato l'esercito. Nel febbraio del 1902, Isabelle e il marito possono tornare finalmente ad Algeri. E questa sarà per Isabelle la rottura definitiva con tutto ciò che la lega all'Europa e a quel che resta della sua famiglia. Rompe anche con l'adorato fratello Augustin. Annota nel suo diario: "....il fratello tanto amato è per me come morto...". Ad Algeri Isabelle diviene amica dello scrittore Victor Barrucand, corrispondente per La Revue Blanche, che cerca di aiutare i due giovani e trova un impiego ad Ehnni come traduttore nella comunità mista franco-araba di Ténès, ad un centinaio di chilometri ad est di Algeri. Là, Isabelle incontrerà un altro personaggio fondamentale nella sua vita: lo scrittore Robert Randau (anagramma del vero cognome, Arnaud) che era nato in Algeria ed era figlio di un colono francese; aveva scritto libri sull'Africa e sulla presenza francese in questa terra. A Ténès era una personalità statale presso la comunità mista, un uomo colto e generoso. Egli ci ha lasciato un preciso ritratto di Isabelle in quegli anni: elegante, vestita alla cavallerizza, con indosso un immacolato burnous, gli stivali alti e rossi degli Spahi, gli occhi neri, la faccia livida, gli zigomi alti e una voce stridula e nasale che colpiva chiunque la incontrasse. A Ténès, Isabelle inizia a scrivere articoli per l'Akhbar, un periodico in lingua araba e filo-arabo, ma la sua salute è sempre più precaria, non fa alcuno sforzo per curarsi. I suoi denti - una volta splendidi - cominciano a marcire, è l'inizio di una decadenza fisica precoce e inarrestabile: ed ha solo venticinque anni! Anche a Ténès Isabelle non sarà risparmiata dalle calunnie. Proprio a causa della sua collaborazione con una rivista filo-araba, viene accusata di influenzare i musulmani della regione, di comprare i loro voti. Il marito è accusato di estorcere denaro agli "indigeni" per sovvenzionare le casse dell'Akhbar. Lei cerca di discolparsi pubblicamente sulla stampa, proclama la sua onestà ma i due vengono comunque sommersi da una campagna diffamatoria. Ancora una volta l'amico Barrucand l’aiuta proponendole ospitalità ad Algeri in cambio della collaborazione all'Akhbar; sa che non troverà mai più una persona come Isabelle in grado di combinare le ambizioni coloniali della Francia e le realtà locali. Isabelle accetta l'offerta che le permetterà di riprendere il suo vagabondaggio nel deserto: l'unica cosa che l'attragga veramente. Nell'anno 1903 approda alla guarnigione militare di Ayn Sefra dove conosce il generale Hubert Lyautey, inviato alla frontiera algerino-marocchina per sedare e sottomettere le tribù ribelli, e che sarà suo intimo amico fino alla fine. Nella guarnigione conosce soldati di ogni nazionalità arruolati nella legione stranera, fuma kif, mangia e dorme pochissimo. Isabelle diventa un’agente per conto di Lyautey: la sua conoscenza degli ambienti musulmani è nota, così come i suoi contatti con le tribù locali e la possibilità di frequentare le zawiya, dove si supponeva fossero i bastioni della ribellione. Inoltre la sua qualifica di giornalista giustifica la sua presenza nelle zone calde e pericolose. I suoi resoconti all'Akhbar costituiscono una riprova di questo suo ruolo; ella afferma che lo sterminio delle tribù dissidenti è inutile, che è sufficiente isolare e mettere sotto sorveglianza i ribelli. I suoi articoli attirano l'attenzione e compaiono anche sulla Dépêche algérienne. Nel dicembre del 1903 torna ad Algeri per trascorrere il Ramadan con Slimène: lui è tubercolotico. Isabelle vive l'ultimo anno della sua vita, il 1904, in modo febbrile, in continuo movimento. Ancora una volta viaggia verso Sud al confine col Marocco, visita la zawiya di Kanadsaa, 20 chilometri a sud-est di Colombe-Béchar in territorio marocchino, quindi torna ad Ayn Sefra che lei considera il suo punto di riferimento e dove ha affittato una casa. Ma gli attacchi di febbri malariche si fanno talmente violenti che è costretta a farsi ricoverare nell'ospedale militare della guarnigione: è il 2 ottobre 1904. Il 21 ottobre Isabelle è impaziente di lasciare l'ospedale, quel giorno Slimène l'ha raggiunta dopo una lunga separazione e lei lo vuole incontrare, contro il parere dei medici che vorrebbero trattenerla. Le casupole di fango costruite a ridosso dell’uadi Sefra, vengono improvvisa- mente sommerse dal fiume in piena che trascina con sé case, bestiame, alberi, persone; la donna - affacciata ad un precario balconcino – sorride, osserva la spaventosa marea che spazza via tutto. Rimane immobile, non fugge, non tenta in alcun modo di salvarsi. Un’onda la travolge. Il suo corpo sarà ritrovato solo alcuni giorni più tardi, sotto le rovine della sua casupola e l'amico Lyautey lo farà inumare nel cimitero musulmano. Questa androgina del deserto, questa amazzone del Sahara, la nomade dal cuore d'oro, corrispondeva perfettamente all'idea dell' 'Oriente' che coltivavano gli Europei all'inizio del secolo. Non ci fu nessun principe nella vita di Isabelle, nessun alto funzionario, nessun appoggio, tutto quello che realizzò fu intrapreso senza nessun aiuto e nella solitudine e rivendicò soltanto la libertà di convertirsi all’Islam e di amare un popolo e un paese - l’Algeria - che non era il suo, e di viverci coraggiosamente da sradicata, pur cercando un’integrazione a prima vista proibita. In un’epoca in cui la vita delle donne era relegata alla famiglia e alla casa, Isabelle fu una donna al di fuori di questi schemi. Fece dell’Islam la sua religione e del deserto la sua casa: lo percorse in lungo e in largo, a cavallo, con una sacca piena di libri e i soli abiti che aveva indosso. Visse in povertà estrema, da nomade con i nomadi, condivise con loro fatiche e malattie. Sia da viva che da morta divenne un mito in Francia, e d’altro canto non si poteva non rimanere affascinati dalla personalità di questa donna non bella, dalla fronte alta e bombata, dagli occhi neri, dalla voce sgradevole che riposa da quasi cent’anni nel cimitero musulmano di Ayn Sefra. R.S
Donne Saracene
“Noi siamo le figlie della stella del mattino; camminiamo sui giacigli molli; abbiamo perle al collo, muschio alla divisione dei capelli; quelli che avanzano alla spugna, noi li abbracciamo, quelli che si ritraggono noi li abbandoniamo”. Così cantava Hind, coi capelli al vento, seguendo i Coreisciti alla battaglia di Ohod e immergendo le labbra nel fegato palpitante di Hanza. Hind è l’Eva barbara del Nedged dell’Hejaz del Yemen, nata la dove il profeta dell’Islam gridò: il paradiso è all’ombra delle spade. Il suo sangue sui innumerevoli innesti lungo tutte le sponde del Mediterraneo, da Damasco a Cordova, a seconda che la Spagna o la Persia, l’Africa dei berberi o dei Mori s’infiltravano nella razza araba conquistatrice. Ne risultò il tipo saraceno, oscillante fra il semitico e il camitico, fra il pastore errante dell’Arabia deserta e il fellah egizio e berbero. Cotesto tipo, che in Algeria in Tunisia ed Egitto va sempre più modificandosi al contatto dei nuovi conquistatori bianchi, qui è ancora intatto e le donne israelite e musulmane sono ancora negli usi e nelle vesti nel sangue e nella lingua, profondamente saracene. Ritengono tutte dall’Arabia la lingua, più dura che nelle altre parti dell’Africa e più rigido ancora il costume tradizionale e immutabile, sia nelle discendenti di Hind sia in quelle di Fathma e di Aisha. Ebree e musulmane, tutte parlano lo stesso arabo, vestono costumi consimili, abitano case dagli stessi arabeschi, dalle stesse logge, dagli stessi cortili e si tingono tutte degli stessi succhi di henna. Ma pure le due diversi leggi, la Bibbia e il Corano, atteggiarono il loro spirito a una profonda dissomiglianza. La moschea e la sinagoga non si fusero mai, benchè Mosè e Maometto adorassero lo stesso Iddio, unico; e quando la donna dell’harem s’incurva adorando, allorché dai minareti giunge l’invito alla preghiera, la donna ebrea passa indifferente, benché il nome Allah anche per lei suoni nome di Dio. E dalle due diverse leggi, nasce una divisione profonda nella vita delle due donne. La casa, che nell’architettura, e nelle sue divisioni, sembra uguale tanto presso le musulmane che presso le ebree, ha dalle porte alle finestre, una diversità sostanziale. Mentre nella Hara le finestre sono munite di sole inferriate e le porte lasciano scorgere i vivaci colori del cortile ove le donne preparano le vivande, pestando, lavando le spezie e gli ortaggi; nel quartiere arabo, invece, le finestre sono nascoste da fitte grate di legno e le porte si aprono su piccoli anditi a sghembo, che nascondono l’interno agli occhi più curiosi. La casa israelita è sonante di voci e di risa; quella musulmana si chiude in un silenzio misterioso. Sulle porte della Hara, nei costumi colorati e scintillanti di metalli, le ebree si appoggiano indolentemente, sorridendo e rispondendo a chi le interroga, con voluttuoso abbandono, mentre tutti i battenti sono inesorabilmente chiusi nel quartieri arabo. Ospitali, liete e freschi di una bellezza di rose di macchia, che traluce dalle formle semiaperte e dalle braccia e dalle gambe seminude, le nipoti di Hind, di Sara, di Rebecca, fanno pensare a rapimenti saraceni su feluche dalle gonfie vele, tra strida e luccicare di denti, e schiuma d’onde percosse dal remo. Adesso, tutta la loro vita trascorre nel cortile quadrato a incrostazioni di maiolica e nelle poche stanze n mezzo alle droghe, agli ortaggi, alle carni, nella laboriosa preparazione dei pasti. Gli uomini lavorano la settimana, per godere i pasti e soprattutto quello del sabato, preparato di lunga mano dalle loro donne. Sono stato a un pranzo nella Hara, in casa di un Rabbi, in una stanza aperta sulla terrazza, inondata dal sole, su cui le donne in gruppi di fiamma e d’oro si aggruppavano, snodando le belle membra calde di vita. Le donne non possono partecipare al pranzo degli uomini; mangiano prima in un’altra stanza. Mentre noi sedevamo alla mensa interminabile, esse vegliavano ai cibi, ansiose dell’approvazione dei commensali. Ognuno di quei cibi che passavano sotto il nostri occhi, era una pagina della loro vita. Passavano più davanti agli occhi che sotto il palato, il nokidis, il mifrum, il kukila, il makud, il kahen, il karkos, il kuskus, miscele laboriose in cui le carni, le farine, le uova, avevano subito giornate intere di immersione, di lavaggi, di condimenti e il vecchio Rabbi, con la fronte cinta da un ampio turbante, sorrideva a capo della tavola, a quella processione di vivande, drogate di tutte le spezie e di tutti i sapori, mentre dalle finestre e dalle porte fiorivano, come cespi di rose, le fanciulle e le donne * Quando giunge l’atteso giorno delle nozze, l’uso saraceno antichissimo vuole che tutte le donne e le fanciulle della Hara partecipino alla festa. Vi è lo Sciabbat el Benat (sabato delle fanciulle) che raccoglie nella casa della sposa tutte le fanciulle israelite, mentre una piccola orchestra suona la darbuka e i dandir, tamburo e cembali, cantando canzoni arabe. Tre notti della settimana, che antecede gli sponsali, sono rallegrate da questa musica e da un corteo. Nel buio delle strade, si vede spuntare un uomo che reca un braciere fiammante seguito da altri portatori di lanterne; si ode la musica dei cembali e una torma di donne passa cantando, gridando, intorno alla sposa; mentre, dalle finestre, altre donne gettano su di lei acqua commista di rosa e gelsomino. Vi è inoltre lo Sciabbat el Hennè che io vidi una sera in una casa della Hara. Il nostro ingresso portò lo scompiglio. Lembi di seta azzurra e rosea, trecce brune e formle d’ogni colore, si videro in fuga per le varie porte. Passata la prima sorpresa, si affacciarono qual e la occhi stellanti, pieni di meraviglia tra gli arabeschi delle pareti di maiolica. In una i quelle stanze v’era la sposa. Ahimè, la cerimonia che si compiva, aveva più del funerale che degli sponsali. La sposa giaceva in terra coi piedi e le mani ravvolte in bende di lana, aveva la faccia coperta da un velo nero e le compagne attorno a lei, negli abiti sfarzosi, assistevano alle applicazioni di henna. Tutte le sere, per l’intera settimana, i poveri piedi e le povere mani della giovine donna, vengono arrossati con i sughi dell’henna finché non siano completamente neri. Questo è il rito; e finché le piante della sposa non sono nere, essa non può avvicinarsi al talamo nuziale. Con una pazienza religiosa, una docilità incantevole, la bella ebrea attendeva la nostra partenza, per ricominciare le applicazioni alle piante. Quando arriva il giorno delle nozze, finite le preghiere, nei pittoreschi cortili, allorché il Rabbi deve benedire gli sponsali, ecco, si vede scendere dalla terrazza, sorretta da tre, da quattro voluminose anziane, la sposa, mettendo un piede innanzi l’altro, come se camminasse sulle spine. Così vuole il rito. Quale sacrificio per le belle ebree, in quel momento, che tutti gli occhi sono dissi su di loro! Esse, che camminano sciolte e leggere, con l’holi di seta bianca sulle labbra, sulla fronte e lungo il corpo agile; che si incurvano con tanta prestezza a gettare l’acqua sui pavimenti, a strofinare le pareti scintillanti, cinguettando un arabo, dolce come il liquore delle palme! Sono gentili di sorrisi, queste arabe ribelli all’islam, fedeli agli antichi Profeti! E tra una parola araba e n luccicare dei denti di perla, incastonano quelle parole italiane che sono loro rimaste dalle lezioni di scuola. Tutte hanno frequentato le scuole italiane; ed è per uno di noi una sorpresa deliziosa, sentirsi salutare e rispondere con qualche parola limpida, nata sulle rive dell’Arno. E sanno anche comprendere la nostra lingua! Nel minuscolo teatro di Tripoli, ove recita una minuscola compagnia italiana qua e là nei palchetti, si vedono sempre, fra i monotoni vestiti europei, come raggi di luce, i vestiti delle israelite. Vi era un palco una sera, di fronte a me, che pareva una scena dalle Mille e una notte; tre piccole ebree; una gara di giovinezza, di splendore, di riso. Vederle ridere era una felicità. Le loro anime semibarbare lanciavano dagli occhi e dalle labbra degli zampilli; mentre nel silenzio della sala, si udivano i debalesc, i dubluni, gli hidaid, collane e monili, urtarsi sul petto e sulle braccia. L’una di esse, sui capelli neri, portava una maharama di seta color fragola, intorno al collo una collana di medaglie d’oro e una tempesta di punti d’oro sui velo della cardia. Un holi di seta bianca copriva la piccola persona. La seconda era bionda, neppure diciottenne, una Huri, dallo sguardo incerto e dal sorriso timido che un leggero imbarazzo rendeva anche più vaga. La terza, che occupava l’interno del palco, pareva, nella penombra, una figlia di re Salomone, nata col Cantico dei Cantici, quando il poeta regale era ebbro delle bellezze terrene. Si protendevano, si agitavano, ridendo, inseguendo le parole della scena, dilatando gli occhi a quelle più ardue; sciogliendosi tutte in una tempesta di luce, quando avevano compreso. Quale più beata visione può offrire la terra? Ogni gesto, ogni atto, ogni flettersi delle figure, ogni scatto di riso era fulmineo, come la loro natura ordinava, immediata era la rispondenza fra il sentimento e l’azione, ogni moto era sincero come la polpa dei datteri e il latte delle capre. Veder ridere così, è come respirare a pieni polmoni l’aria del mare con i piedi sulle rocce stillanti e la fronte al vento. Nella casa musulmana, le stanze hanno uguale architettura. Ai due lati, si flettono due vòlte da cui pendono cortinaggi che velano i letti. Il letto consiste in un largo materasso, capace di due persone, che giace sopra un vero edificio di legno incardinato alle pareti. Una piccola ringhiera corono l’armadio-letto e alcuni scalini aiutano l’ascensione. Se la casa è ricca, il legno è intarsiato, e contiene cuscini trapunti e tappeti a profusione. Le musulmane di Tripoli, siano indigene o levantine, si alzano presto e appena levate prendono il the e una specie di basina condita col burro e il miele che basta loro fino a ora tarda. Nella mattina escono, poi per lo scambio delle visite; le levantine velate di nero; le tripoline, chiuse nelle bianche pieghe dell’holi, incrociato sul volto. All’ora della preghiera, viene distesi uno speciale tappeto, su cui si prosternano, pregando insieme Sono liete e spensierate, ignare del domani, gorgheggianti come usignoli e soggette a due solo cose: il velo e il loro signore. Quando una di esse lo disgusta, egli può con due solo parole: sia divorziata! Cacciarla di casa per sempre; né può riprenderla, prima che essa abbia contratto altre nozze e subito nuovo divorzio. Con questa facile alternativa, una donna può variare sette, dieci mariti. Perciò un divorzio è più grazioso della loro commedia domestica; la quale del resto, può tramutarsi rapidamente in tragedia, non appena un estraneo ardisca penetrare la casa araba. La proprietà della casa e delle donne giunge, presso gli arabi di Tripoli, al parossismo religioso. Se alcuno penetra il segreto del volto di una di esse, commette un sacrilegio, che l’arabo selvaggiamente punisce con la morte. Trovare un uomo in casa o sotto le proprie finestre, non ha che una logica conseguenza: ammazzarlo. Di questa gelosia sensuale e mistica, la donna musulmana prende quasi sempre vendetta fuori dalle mura dell’harem. Può spesso accadere che essendo così velate, il marito si imbatta per la strada, nella propria donna, senza riconoscerla. Ma il peggio è che codesta gelosia religiosa non si limita alle moglie ma si estende a tutte le donne, purché appartengano alla loro razza e al loro culto. Al Cairo, Algeri a Costantinopoli, si vedranno le donne arabe, seguaci di Maria di Magdala. commiste a quelle di ogni altro paese; qui a Tripoli, invece, anche codeste subiscono una reclusione ferrea, persistendo inattaccabile il fanatismo religioso. È una orribile gelosia di razza, una specie di vigile custodia, di spionaggio, che ogni arabo esercita su tutte le donne della sua origine. Anche il più piccolo scoiattolo dalla camicia stracciata se vedrà una donna araba a fianco di un uomo o se la scorgerà uscire da un’altra casa, con qualche sospetto, chiamerà a raccolta e all’improvviso una torna di uomini i precipiterà sulla donna e su chi l’accompagna o la segue. Un’araba, nell’uscire da un convegno, fu sorpresa da un pezzente che, obbedendo ad un sacro dovere, si slanciò su di lei strappandole il vela dalla faccia per riconoscerla ed accusarla. La donna, supplicandolo di tacere non poté sfuggirgli che lasciando piovere nelle mani di lui, tutti i suoi monili e le gioie che aveva addosso. Tripoli è sempre rigurgitante di oziosi, pronti a simil genere di scandagli; perciò è piena d’inciampi qualunque avventura. Accade qui, parlando delle donne arabe, di vedere tutti i volti oscurarsi, come di fronte a un mistero impenetrabile che ha la morte per necessaria conseguenza. Quando io arrivai, chiesi ad alcuni giovani di Tripoli: “avrete tutti delle amanti arabe, se sono, come corre voce, di così grande bellezza?” I giovani tripolini sorrisero, percossi da stupore. Nessuno di essi aveva un’amante araba, non solo, ma nessuno ardiva, per timore degli Arabi, di avvicinare quelle già note. Nella loro spensierata letizia, quelle farfalle dorate si compiacciono poi segretamente di mille avventure, con arabi, s’intende. Mi narravano di un giovane che ebbe finalmente dalla moglie di un ricco arabo, per nome Khadigia, di meravigliosa bellezza, la grazia di un convegno nell’harem: ma, temendo un inganno, egli si astenne dall’andarvi, pensando di rinviare al giorno seguente il ritrovo. Incontrata Khadigia, questa gli chiese il perché dell’assenza ed egli rispose che era stato a Zanzur e che sarebbe entrato all’istante. Entrarono e di li a poco la porta fu percossa con violenza. Come fare? Kadigia sorrideva placidamente: chiuse la camera, pose le sue scarpe davanti alla porta e si fece incontro all’adirato signore che impugnava una splendida rivoltella damaschinata. -- Vi è qualcuno!! - Urlò l’arabo furibondo. - Non vi è nessuno, mio signore - rispose sorridendo Kadigia. - Là dentro vi è qualche infedele - riprese il marito slanciandosi verso la porta - nella mia camera vi è una donna, l’amica mia Massuda e voi non potete entrare. Se io fossi presso una mia cugina, vorreste voi che un uomo vedesse il mio volto? Così voi non potete vedere l’amica mia – Questo argomento fu convincente, infatti nessun arabo può entrare dove sia chiusa una donna, che abbia lasciate le sue scarpe alla porta. Il marito depose la rivoltella damaschinata e s’avviò per i suoi affari, mentre Kadija rientrava placidamente con l’amico. Passano, sormontando con disinvoltura i promontori e le insenature delle vie di Tripoli e provocano spesso solenti abbagli, così da seguire ansiosamente tutta chiusa nei veli, qualche antichità rispettabile. Tuttavia, le scarpine di vernice, invece dei lunghi sandali di pelle gialla o rossa, e un lieve profumo di gelsomino, possono essere indizi sicuri di giovinezza. Ma chi le vede? Sono misteri che passano, segreti che non sapremo mai. Ogni mattina, io comincio a percorrere l’alveare delle strade, che nessuno designa per nome, perché i nomi sono graffiati in turco a qualche angolo e consunti dalla pioggia e dal sole; “sperando di penetrare questi segreti, scrutando ogni velo nero, ogni holi bianco e non vedendo che volti in ombra o un occhio solo, fra i due lembi incrociati. Percorrere e ripercorrere le stesse strade in questa ricerca inutile, è un destino a ci non possiamo ribellarci. Chi può rinunciare alla felicità, benché la sappia eternamente lontana? Esse hanno la bellezza del mistero; sono simili alle conchiglie, che portano il ronzio del mare. Che cos’è una conchiglia? Un piccolo guscio con l’anima del mare. Queste creature velate, sono l’involucro di una cosa grande ed eterna più del mare; il sogno umano. Entravo una mattina nel quartiere arabo, e mi fermai distrattamente avanti a un forno, uno di quei bassi forni oscuri su cui i due negri accumulano il combustibile di sterco, estraendone poi, con la pala, i pani dorati. Guardavo i due negri, specie di trogloditi, dal corpo scheletrico coperto appena da due stracci di stoffa consunta e pensavo a quelle vite miserabili trascorse in quel fetore quando due leggeri passi risonarono in fondo alla via. Mi voltai; era un’araba, seguita da una sua piccola fante negra. L’holi di seta bianca stringeva delle forme eleganti ma il fitto velo nero m’impediva di vederne il volto. Mi avanzai verso di loro e l’araba, vista deserta la strada, con un gesto pieno di grazia deliziosa, prese con la punta delle dita la veletta nera e la rialzò sulla fronte, offrendomi un viso ridente, creato per il divino Gennai, lassù ove i fedeli godono le delizie del korkan tra fontane d’acqua di rose, in palazzi di diamanti, ove scorre il fiume Kantser dalle sponde d’oro, con la ghiaia di perle e rubini, le acque più dolci del miele, le schiume più lucenti delle stelle. È passò oltre; io mi rivolsi, e la piccola fante mormorò una parola alla sua signora, che si voltò, lanciando indietro tutta la veletta nera, con un sorriso smarrito nell’ombra della volta. Alcuni arabi spuntarono a un crocevia e si arrestarono di botto. Io passai davanti a loro, fumando tranquillamente, e vidi la mia araba arrestarsi, raccogliere una piega dell’holi e, poi entrare in un negozio di stoffe, soffermarsi un istante ed uscirne. Avanti ancora, una strada un volto oscuro, un altro, sbucai nel bazar degli orefici. Nel seguirla, mi fiorivano alla memoria i versi di un antico poeta arabo: “la vita è agli occhi miei un tesoro di cui ogni notte rapisce una parte”. La donna velata fece alcuni passi ancora e percorse con un rapido volger del capo, le piccole officine, dove gli argentieri battevano e bruciavano l’argento. Finalmente, qualche cosa l’arrestò e di li a poco vidi tra le sue mani una collana d’argento, tutta traforata a piccole mezzelune. Guardò a lungo la collana, la fece scorrere tra le dita e non parve contenta, la depose tra le mani dell’argentiere e riprese il cammino indolentemente, lo volevo sapere ad ogni costo dove abitava, quindi raddoppiai la prudenza; e per grazia del Profeta, non fui deluso. Di lì a poco, in una stradicciuola mezzo tagliata dal sole, ove due piccoli arabi stritolavano dei semi di palma, la donna si fermò e batté a una porta di vecchio legno intagliato ad arabeschi, contornata da uno stipite di mattonelle rosee, disegnate a foglioline di mirto. Una voce dall’interno proferì un nome: “Lubna”! L’araba risposte con la voce; era quello il suo nome, i due piccoli scoiattoli, appena mi videro, si fecero sospettosi e gridarono. Lubna scomparve. Io gettai un pugno di parà nella strada attigua e i due piccoli arabi si lanciarono a raccoglierli; alzai gli occhi e vidi l’ombra di Lubna, dietro le grate, l’ombra sorridente, senza velo. Udii un mormorio di parole, di quelle rapide voluttuose parole arabe. - O Allan el Fandi, benedetto dall’Onnipotente, io dissi ripetendo i versi di Antar, questo vino è più dolce che nettare, perché mi viene versato dalle mani della bellezza – Lubna, Fathma, Aisha, Mabruka; Massuda, Hlima, Kammuna, nomi mormorati dietro il minuto incorcio delle grate o sui tappeti di Damasco, o sotto le cupole delle moschee, io invidio che vi ama laggiù, tra le vie di Si-el-Hadar, di Diami-el-Droug, di Bab-el-Bahar Quali prove per voi, o figlie della stella del mattino, non vinse chi vi amava Via tra le rupi e le sabbie, cavalcavano per voi gli eroi del deserto, cantando: “Leoni, seguiteci, perché vedrete sparsa la terra dei cadaveri”; né scendevano dal cavallo o dal cammello infaticabile, prima d’aver vinta ogni prova, né conquistavano voi, o sorelle della luce, senza aver vegliato intere notti in agguato, senza aver strappato ai leoni la ribelle criniera. Allora soltanto, sul cavallo lanciato a corsa, come un macigno trascinato da un torrente, riapparivano i poeti arabi, con la testa del nemico infilata nella lancia, gridando:”Se io non temessi traccia d’orgoglio, direi che il mio braccio basta per scrollare l’universo” Lontane voci, morte nel tempo, eterne nell’amore, risonano all’orecchio di chi contempla un istante i vostri occhi: molle e feroce, la poesia araba vi circonda di bende di fiamma. Per un attimo, ritorniamo soli, nude anime primitive e viviamo quella vita, desiderosi che la vostra immagine non si estingua mai, desolati al vostro sparire, come allo sparire del sole, quando si affonda tra le arene del Sahara. Laggiù, alle fauci del deserto, sul bagliore della sabbia fulva, un punto nero, a poco a poco si dilata; è un cammello, e un altro e un altro ancora. Vengono da Garian o da Yefren, da Ghadames o da Murzuk, portando delle figure velate, ondeggianti come sopra una cuna, ravvolte in un nembo di sabbia e di sole, come idoli in un incenso, trasfigurate nella nebbia aurea, in forme inafferrabili al di la dei sensi e della vita; e a chi le guarda destano una nostalgia amara di contrade lontane, di forme nuove, una irrequietezza insaziabile e il tormento di dover morire, senza aver conosciuta e amata tutta la bellezza barbara e inesauribile del mondo! D.T.
|
|
|






